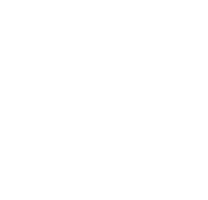«Rinascimento» è la rivista dell’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento. Fondato con decreto-legge 29 luglio 1937 l’Istituto – che assume la denominazione attuale nel 1942 – ha il «compito di promuovere, coordinare e diffondere ricerche e pubblicazioni» intorno al Rinascimento italiano ed europeo. Un compito per il quale fin dall’inizio la rivista svolge un ruolo fondamentale affiancando, e integrando, le pubblicazioni di studi e testi che l’Istituto promuove e cura.
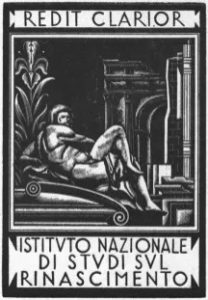
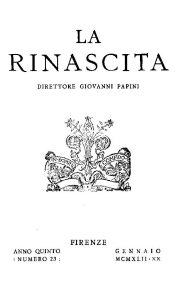
Originariamente il periodico si intitola «La Rinascita» e ha cadenza trimestrale, poi mutata in bimestrale. Durante i suoi sette anni di vita, dal 1938 al 1944, «La Rinascita» è specchio fedele delle differenti e opposte anime compresenti nell’Istituto presieduto da Giovanni Papini, che dirige anche la rivista, nella quale retorica di regime e concezioni del Rinascimento fortemente ideologizzate si alternano a studi di alto profilo di assoluta novità e rilievo nel panorama internazionale, dando spazio a contributi documentari ed eruditi, ricerche filologiche (come le Miscellanee di filologia umanistica di Alessandro Perosa), testi inediti e, a dispetto delle difficoltà dei tempi, un’ampia informazione bibliografica. I numeri della prima annata, 1938, ospitano la recensione di Eugenio Garin al Supplementum Ficinianum di Paul Oskar Kristeller (annoverato nell’elenco dei collaboratori), il contributo di Hans Baron su Lo sfondo storico del Rinascimento fiorentino, lo studio di Garin su La ‘dignitas hominis’ e la letteratura patristica. Negli anni della guerra i fascicoli si assottigliano. Sull’ultimo, il numero 35 del 1944, all’indomani della morte di Gentile, esce lo scritto di Garin Giovanni Gentile interprete del Rinascimento.

Dopo l’interruzione del dopoguerra, l’Istituto viene ricostituito ufficialmente nel 1949 esaudendo i voti di numerosi intellettuali italiani, europei e statunitensi – Kristeller in prima fila – per una ripresa delle attività e della rivista. Che assume ora il nome «Rinascimento»: a dirigerla è Mario Salmi, presidente dell’Istituto; Garin, membro del nuovo Consiglio, è a capo della redazione. La prima serie di «Rinascimento», iniziata nel 1950 con periodicità dapprima trimestrale, poi semestrale, accoglie le ricerche di quelli che erano o diventeranno nomi importanti negli studi sul Rinascimento, quali Cesare Vasoli, Antonio Rotondò, Giuseppe Billanovich, Luigi Firpo, Cecil Grayson, Ugo Procacci, François Secret.

A partire dal 1961, in concomitanza con il nuovo statuto dell’Istituto, viene inaugurata la seconda serie di «Rinascimento». La struttura è ripensata secondo una rinnovata esigenza di rigore voluta da Garin, che siede nel Consiglio in qualità di vicepresidente e presto affianca Salmi alla direzione della rivista: un unico volume, annuale, organizzato in sezioni volte ad accentuare «il carattere di raccolta di contributi storici ed eruditi» (la rubrica «Saggi e testimonianze») e di edizioni di testi e documenti, frutto di ricerche originali (la rubrica «Testi e commenti»), spaziando in tutti i campi in cui l’Umanesimo e il Rinascimento si sono manifestati: «dalle lettere alle arti, dalla filosofia alle scienze». È principalmente attraverso l’offerta di questi materiali – la cui consultazione è agevolata dal prezioso corredo di indici dei nomi e delle fonti manoscritte – che la rivista intende partecipare al dibattito internazionale sul Rinascimento, promuovendo un importante rinnovamento che coinvolge sia la metodologia che gli ambiti di ricerca. Possono essere qui ricordati, a titolo di esempio, i contributi di Robert Klein, Mario Martelli, Carlo Dionisotti, Lech Szczucki, Christian Bec, Lucia Cesarini Martinelli.
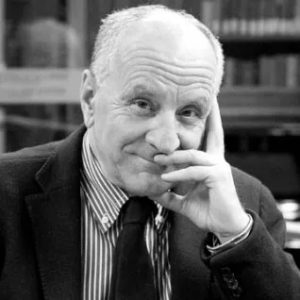
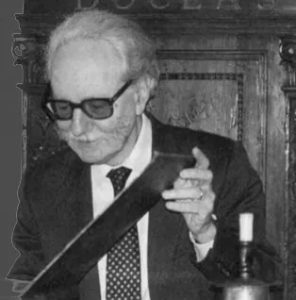
In qualità di presidenti dell’Istituto dirigono la rivista Eugenio Garin (dal 1978 al 1988), Cesare Vasoli (1988-1996) e Michele Ciliberto (dal 1997). Nel corso degli anni nuove rubriche hanno ulteriormente articolato la fisionomia di «Rinascimento»: fin dal 1966 si aggiunge «Note e varietà»; recentissima invece è la rubrica «Discussioni». Sono usciti numeri speciali monografici dedicati interamente o in parte ad autori e temi di rilevante significato nella ricerca storiografica sull’Umanesimo e sul Rinascimento: il volume XII, del 1972, è dedicato a Leon Battista Alberti; nel 2000 esce il volume XL dedicato a Giordano Bruno, in occasione del quarto centenario della morte del filosofo. Il numero XLIII, del 2003, si apre con una sezione sulle tendenze storiografiche e sulle prospettive di ricerca sul Rinascimento attive negli Stati Uniti. Nel 2008 la rivista ospita gli atti del convegno internazionale Filosofie e teologie nella cultura moderna.
Dal 1986 al 1989 viene pubblicata, con paginazione autonoma, la «Bibliografia italiana di studi sull’Umanesimo e il Rinascimento»: un censimento di libri e articoli (dallo spoglio di circa 120 periodici) usciti l’anno precedente e di argomento relativo ai secoli XIV-XVI. Per rispondere alla sentita esigenza di offrire aggiornamenti sullo stato degli studi e delle edizioni un’impresa come quella, meritoria, della «Bibliografia italiana di studi sull’Umanesimo e il Rinascimento» risulterebbe oggi forse anacronistica, a fronte dei repertori a stampa e on line appositamente dedicati e dei mezzi informatici a disposizione. «Rinascimento» ha perciò preferito offrire delle rassegne bibliografiche ragionate sui grandi protagonisti del Quattro-Cinquecento: il volume del 2014 ha accolto la rassegna bibliografica su Jean Bodin; sono in preparazione lavori analoghi su Leon Battista Alberti, Leonardo da Vinci, Niccolò Machiavelli, Giordano Bruno e Tommaso Campanella.
Un ultimo aspetto da sottolineare è l’attuale intensificazione della collaborazione con i maggiori studiosi statunitensi del Rinascimento, secondo una linea che d’altronde ha da sempre contraddistinto la rivista.